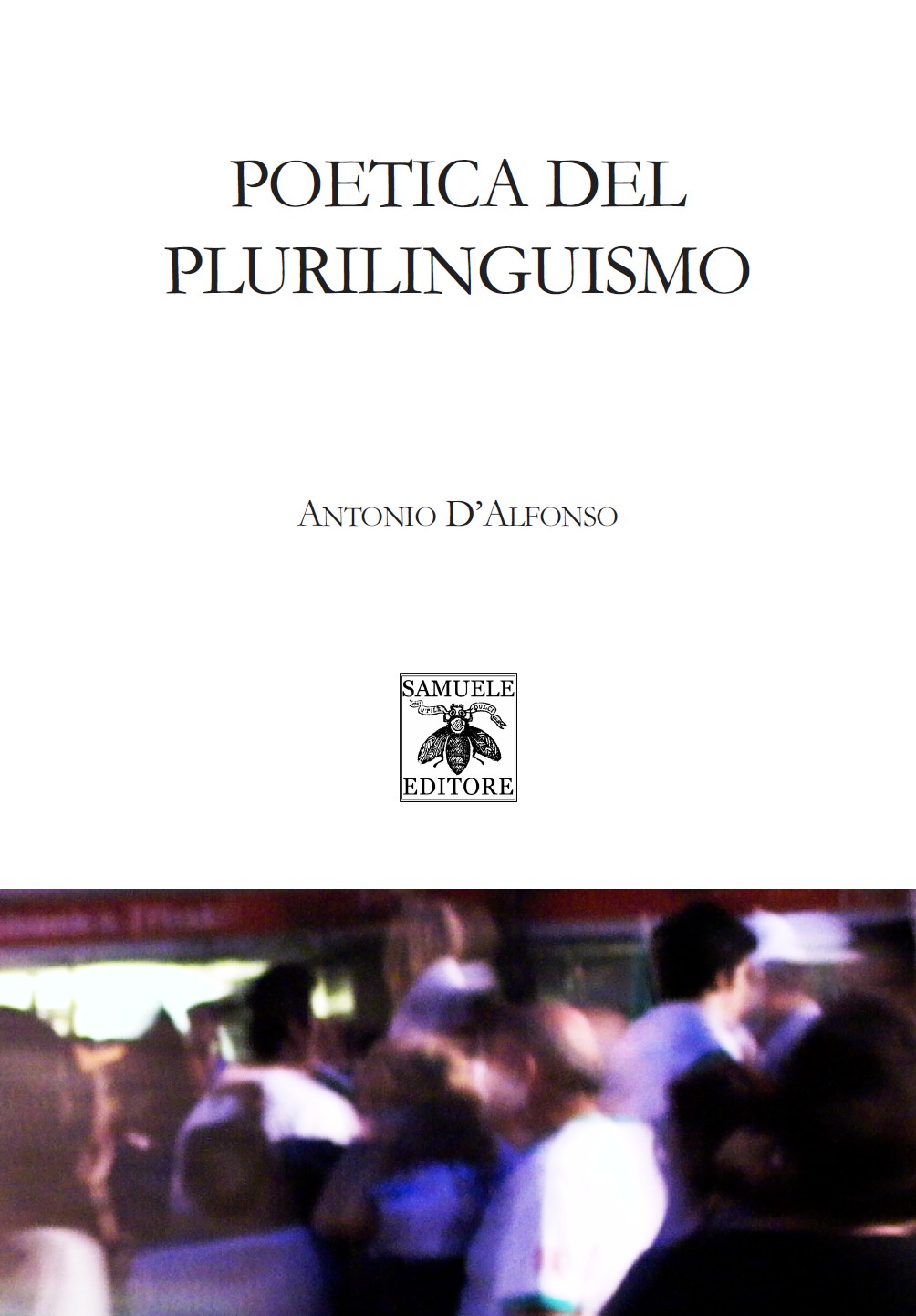POETICA DEL PLURILINGUISMO
Per evitare una Babele post-moderna
Antonio D’Alfonso
traduzioni di
Nicola Gasbarro e Giulia De Gasperi
Collana I Saggi
62 pagine
ISBN 978-88-96526-57-6
Prezzo 12 €
alcuni estratti
Non basta parlare più lingue per comprendere ciò che si dice oltre il recinto in cui ci siamo rinchiusi. Ci si può chiedere di credere all’esistenza di un paese in cui i cittadini parlano più lingue? Esiste veramente questo paese? Leggendo i giornali e guardando la televisione potremmo tutti arrivare a una conclusione scontata e scoppiare così a ridere. Ammettiamo pure che molte persone abbiano appreso più lingue e che queste offrano contenuti molto variegati: come giudicare queste lingue e questi contenuti a livello sociale, giuridico e culturale?
L’unica lingua parlata da un numero sempre crescente di persone è quella del denaro: non del denaro in sé – la carta, il metallo, o quello virtuale – ma del potere di credito di chi si presenta a un qualsiasi negoziante con questo documento simbolico che chiamiamo denaro. Eppure la lingua, nonostante i grandi studi sulla cultura, a volte burocraticamente noiosi, non ha nulla a che fare con il denaro. Alcuni potrebbero persino arrivare a dire che il denaro liquido ha perso potere di acquisto nel commercio di ogni tipo, e che la lingua parlata da tutti è il credito, non il denaro. Quindi: la lingua è un credito?
Più mi si fa credito, più sono ricco; più divento ricco, più mi sento forte! Non potente, però, perché continuo ad essere paradossalmente debole pur con tutti questi bigliettoni (dopotutto la durata del credito non è mai eterna): sono ricco fino a quando la banca non reclama i suoi prestiti. In definitiva io vivo fino a quando dura il credito! E così la lingua. Io possiedo una lingua solo poiché mi si concede il diritto di utilizzarla.
Ogni lingua è insieme apertura e chiusura: se certe barriere si aprono, altre inevitabilmente si chiudono. La lingua che parlo mi conduce giocoforza verso un punto, un punto forte che mi attende alla fine della sentenza, un punto morto. Non sono mai completamente libero di parlare e, in questo mondo-spettacolo di pubblicità uniforme sono sempre meno libero di prendere la parola. Ogni volta che desidero parlare è necessario che alzi la mano per chiedere il permesso. Chi parla non è chi vuole parlare, nei nostri paesi in cui i circuiti di comunicazione hanno pochi padroni e poche firme. L’indipendenza del mercato della parola in realtà si presenta molto più scarsa di quanto ci si voglia far credere.
Io posso parlare una lingua che il mio vicino non conoscerà mai: ogni vicino nella sua prigione del linguaggio. In qualche modo, a furia di sentire tutte queste lingue parlate in diverse sedi, possiamo dedurre che la lingua, a guisa della religione, diventa sempre più una pratica privata, completamente lontana dalla società generale. La parola è un segreto domestico. Ciò che dico è sempre rivolto solo a un gruppo di amici. A volte ci può anche essere una convergenza tra il privato e il sociale, ma è solo una coincidenza; ogni lingua parlata in pubblico è quasi l’effetto di un incidente di percorso. Se in certi ambienti ristretti si arriva a parlare una lingua particolare, questo accade solo perché si è costituita a bella posta una maggioranza di persone che parlano la medesima lingua e nel medesimo momento, con la complicità di una polizia coloniale e linguistica. Se molte persone scendono per strada a parlare nella stessa lingua (vernacolo, dialetti) in parte simile alla lingua di chi ha il controllo legislativo del territorio, basta un nulla per far passare delle leggi che decretano l’ufficialità di quella lingua specifica, e tutte le altre restano private. Proprio come il denaro. Quale sarà quindi la lingua capofila?
[…]
I nostri racconti individuali possono essere osservati attraverso lenti psicologiche, ma possono anche essere studiati con lenti sociologiche. L’esagerata autoesaltazione è la naturale estensione delle cronache del potere che esercitiamo sulla servitù. L’analisi genetica degli italiani dimostrerà quanto le nostre genealogie siano molto più affascinanti delle nostre finzioni, spesso limitate. Se si guarda alle loro origini, pochi possiedono un lignaggio che non sia misto. Milioni d’italiani hanno viaggiato lungo la penisola e attraverso il globo per trovare riparo da traumi politici, religiosi, finanziari e personali. Nel frattempo, Marinetti e i suoi colleghi artisti, D’Annunzio e i suoi amici, Mussolini e le sue conoscenze politiche scavavano buche e puntavano a una finta legittimità neo-classica in modo da poter trasformare la finzione in realtà terrifiche.
Sebbene gli italiani siano stati rapidamente assolti dalla colpa di aver oppresso le minoranze e gli anti-nazionalisti nel secolo scorso, non si può dimenticare che hanno contribuito fin dagli inizi alla creazione di una storia alquanto nazionalista. Con la sua riforma del 1923 il filosofo italiano Giovanni Gentile condannò sbrigativamente ogni cittadino italiano che non parlava italiano. La polizia linguistica italiana attraverso l’abolizione, la proibizione e infine la folclorizzazione dei tanti dialetti, eliminò vasti elementi culturali che costituivano l’essenza stessa della cultura italiana.
Sebbene il fascismo si sia suicidato, le sue teorie ben sopravvivono in molti dei nostri contemporanei. Il cittadino meno desiderabile è lo straniero con il velo che rinchiudiamo dietro le sbarre dell’ostracismo. Quando l’astronauta guarda il pianeta sorgere, non vede barriere. Per parafrasare Ulrick Beck, ciò che offre il transnazionalismo, qualsiasi cosa esso sia, si trova al lato opposto del nazionalismo e riguarda le collettività e le società e non lo stato-nazione. Oltrepassare i confini nazionali fa nascere uno spirito cooperativo che non si trova se invece si guarda indietro: il passato, infatti, ci ricorda quale strada non si deve imboccare di nuovo.
La nostalgia, il desiderio di un ritorno a casa corrisponde all’evocazione del nazionalismo latente. La nostalgia del passato non deve essere confusa con il lavoro che ancora ci attende. Le lacrime versate esprimeranno pure dolore, ma il dolore costruito come una prigione non rappresenta una soluzione. Non c’è un luogo fisso d’origine. Ciò che consideriamo come un punto di partenza è contaminato dall’incertezza e dall’incredulità. Non c’è un posto che possiamo chiamare casa. Il nostro passato è un mosaico che rivela variati paesaggi di un barocco nuovo, non un unico contenitore stato-nazione, per usare l’immagine di Anthony Gidden. Unendo lo stato alla nazione, la società moderna ha sostenuto le masse di dissidenti che devono aderire a una struttura sociale approvata. L’accettazione di questo comportamento è chiamata integrazione. Il ghetto alla fin fine non è altro che uno spazio indipendente all’interno del contenitore e rappresenta una parte di una qualsiasi città dove le persone cantano in armonia. Il problema è che quelli che si trovano al di fuori del ghetto percepiscono la musica come fosse un rumore caotico. Se un vocabolario annerisce questa voce con aggettivi eticamente plumbei, allora questa dissonanza è descritta come l’opera di degenerati. Quando l’invidia verso i barbieri e i sarti che hanno ideato i completi e i vestiti di questi emarginati si trasforma in odio e antisemitismo, la violenza inizia a colpire senza pietà. Aggettivi dispregiativi e ignoranza demonizzano i ghetti. Perché? I ghetti sono società che si autocontengono e che non scompaiono nell’unicità dello stato-nazione. I ghetti sono la prima attualizzazione del pluralismo in qualsiasi nazione. E questo è un bene.
Sull’autore
Antonio D’Alfonso, poeta, scrittore, saggista e traduttore, ha pubblicato più di quaranta titoli e tre film. È stato uno dei padri fondatori della casa editrice Guernica Editions che ha diretto per trentatré anni e che ha poi consegnato nelle mani di nuovi proprietari nel 2010. È inoltre stato tra i fondatori dell’Associazione Scrittori/Scrittrici Italo-Canadesi. Ha vinto il premio Trillium, il premio Bressani e altri riconoscimenti; il film Bruco ha vinto due premi al New York Independent Film Award. In Italia ha pubblicato il romanzo La passione di Fabrizio, tradotto da Antonello Lombardi (Cosmo Iannone Editore, 2002), e il libro di saggistica In corsivo italico tradotto da Silvana Mangione (Cosmo Iannone Editore, 2009). Ha conseguito un dottorato presso il dipartimento di italianistica dell’università di Toronto. Traduce opere di poeti italiani, belgi, francesi, canadesi e statunitensi. Attualmente sta organizzando una mostra di fotografie che ha scattato nel corso di oltre quarantacinque anni.