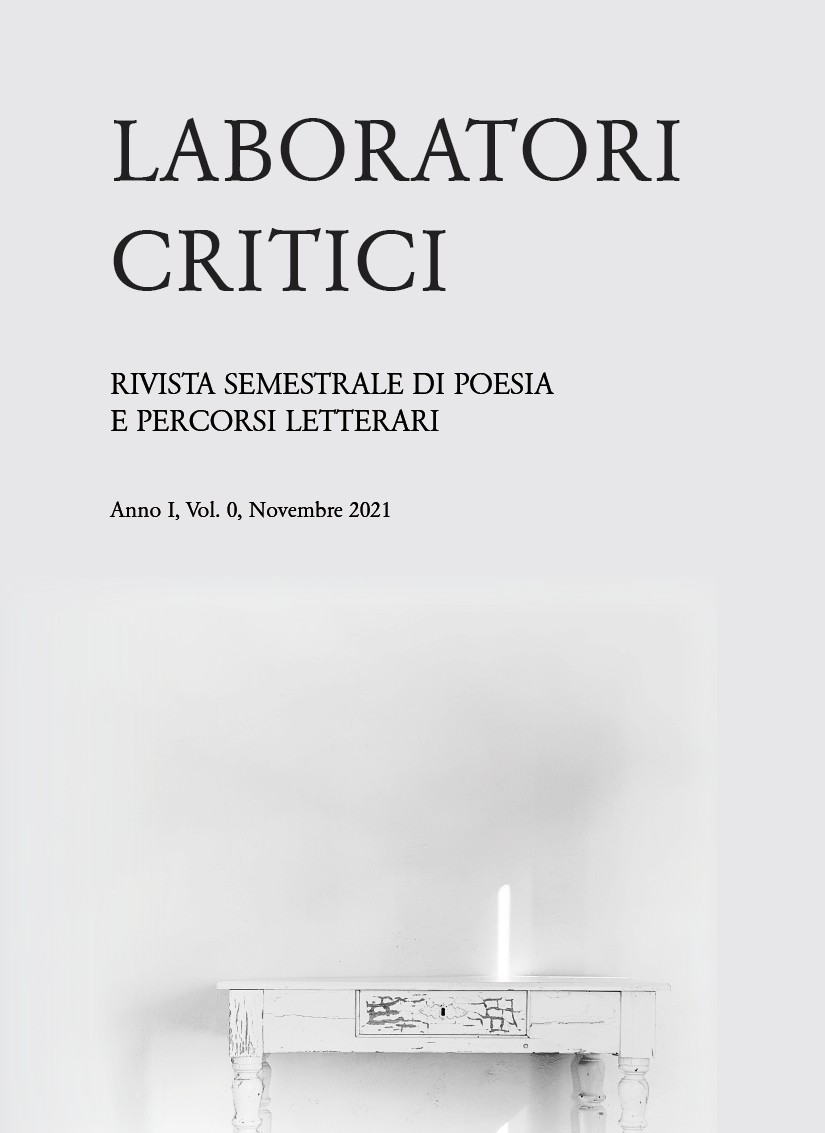
«Tutto sembra quasi poter rivivere, in questi giorni di primo autunno, come se niente fosse cambiato, anche se sappiamo che non è così, e che non potremo mai più essere come prima. Il senso di mortificazione che tanta parte di umanità ci ha inflitto nell’ultimo anno e mezzo, non potrà mai essere dimenticato». È stata una mail cristallina di Giancarlo Pontiggia, amara quanto intellettualmente onesta, a spingermi a cercare le risorse del silenzio nei versi inediti suoi e di Stefano Raimondi che ho proposto nel numero zero di “Laboratori critici. Rivista semestrale di poesia e percorsi letterari”, edita da Samuele Editore.
«Ci sono amici che ci hanno ripugnato con le loro sciocchezze; e altri che ci hanno fatto pena, come se ci fossimo trovati di fronte a degli sprovveduti – incalza il poeta – eppure non lo erano, e qualcuno di loro pareva persino possedere una testa. Evidentemente era tutto apparenza, buone maniere, una vernicetta di conoscenze a buon mercato che copriva una millenaria, cronica stupidità sociale, fatta di populismi e irrazionalismi assortiti. Forse la rivoluzione illuministica, nella quale abbiamo confidato, era solo un’illusione. O forse gli uomini non sono altro, nel loro complesso, che una razza fragile, accasciata, autolesionistica, volta più al male che al bene, duramente provata dal suo stesso vivere. Da un vivere troppo al di sopra delle loro reali possibilità. La nube della morte, che sempre ci tallona, oscura ogni nostra volontà, ogni nostro minimo pensiero». L’oblio sarebbe provvidenziale, anche perché «dopo tanto Novecento e tanta Action Française, dopo Mussolini, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, dopo innumerevoli pessime recite, la prossima stagione del mondo rischia di ripresentarsi con gli stessi lustrini di prima: molte parole d’ordine, molto politically correct, pensieroni di niente».
La becera utopia che ci avrebbe voluto tutti proni a clichés abusati e a un progresso disumano pare sia appassita. Per non tornare sudditi di scelte politiche spesso illogiche, benché abili a camuffare errori di ogni genere, si dovrebbe rileggere il Leopardi de La Ginestra; sarebbe sufficiente per spazzare via qualsivoglia pseudo-certezza di cui ci si fosse paludati in precedenza, scordando la fragilità e la precarietà della condizione umana. Prendendo le mosse da un preciso assunto polemico – la contestazione nei confronti sia del «secolo superbo e sciocco» sia del suo orgoglio prometeico, vuoi del vacuo ottimismo provvidenziale – il canto si rivela capace di conferire alla cognizione dell’infelicità comune un senso agonistico nell’appello a una solidarietà rinnovata tra tutti gli esseri. Sotto la specie dell’umile ginestra si disegna così un atteggiamento nient’affatto pacificato e distaccato, ma anzi critico rispetto all’insignificanza dell’esistenza universale, sia alla necessità di una resilienza morale tramata finalmente di consapevolezza. Infatti come la ginestra con l’ostinato ricrescere del suo manto fiorito riconferma un amore alla vita traente e il suo significato dà consenso a un meccanicistico destino universale, così l’essere umano può trovare una via di autentica grandezza soltanto nella scoperta della “forza della debolezza”, ovvero nel convogliamento della coscienza di precarietà e miseria verso il superamento di ogni orgoglioso o rassegnato isolamento intellettuale in una «social catena»; in una sfida solidaristica – e non solitaria – proclamata in nome e a dispetto di qualunque mistificazione e banalizzazione religiosa o politico-sociale: «Libertà vai sognando, e servo a un tempo / vuoi di novo il pensiero, / sol per cui risorgemmo / dalla barbarie in parte, e per cui solo / si cresce in civiltà» (vv. 72-76).
Matteo Bianchi
Continua su Nazione Indiana

