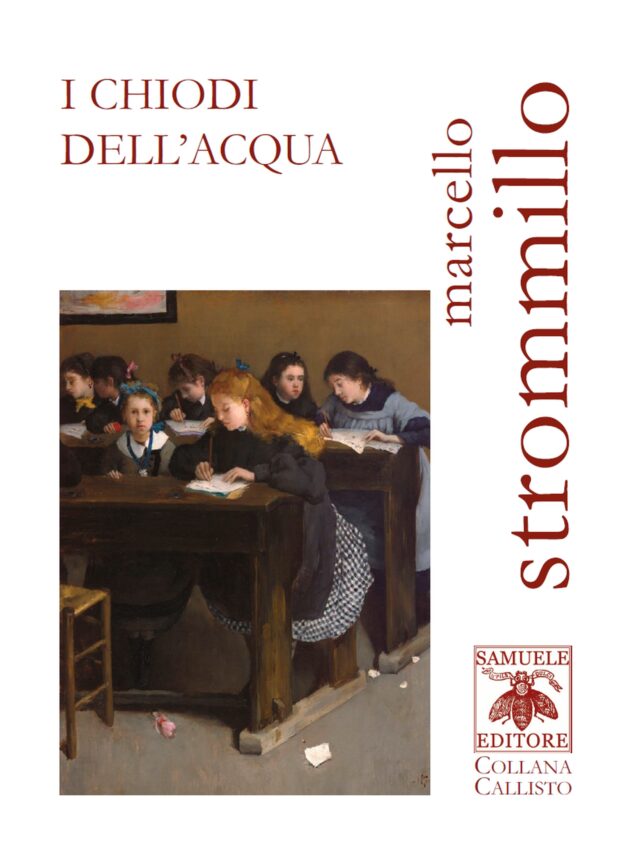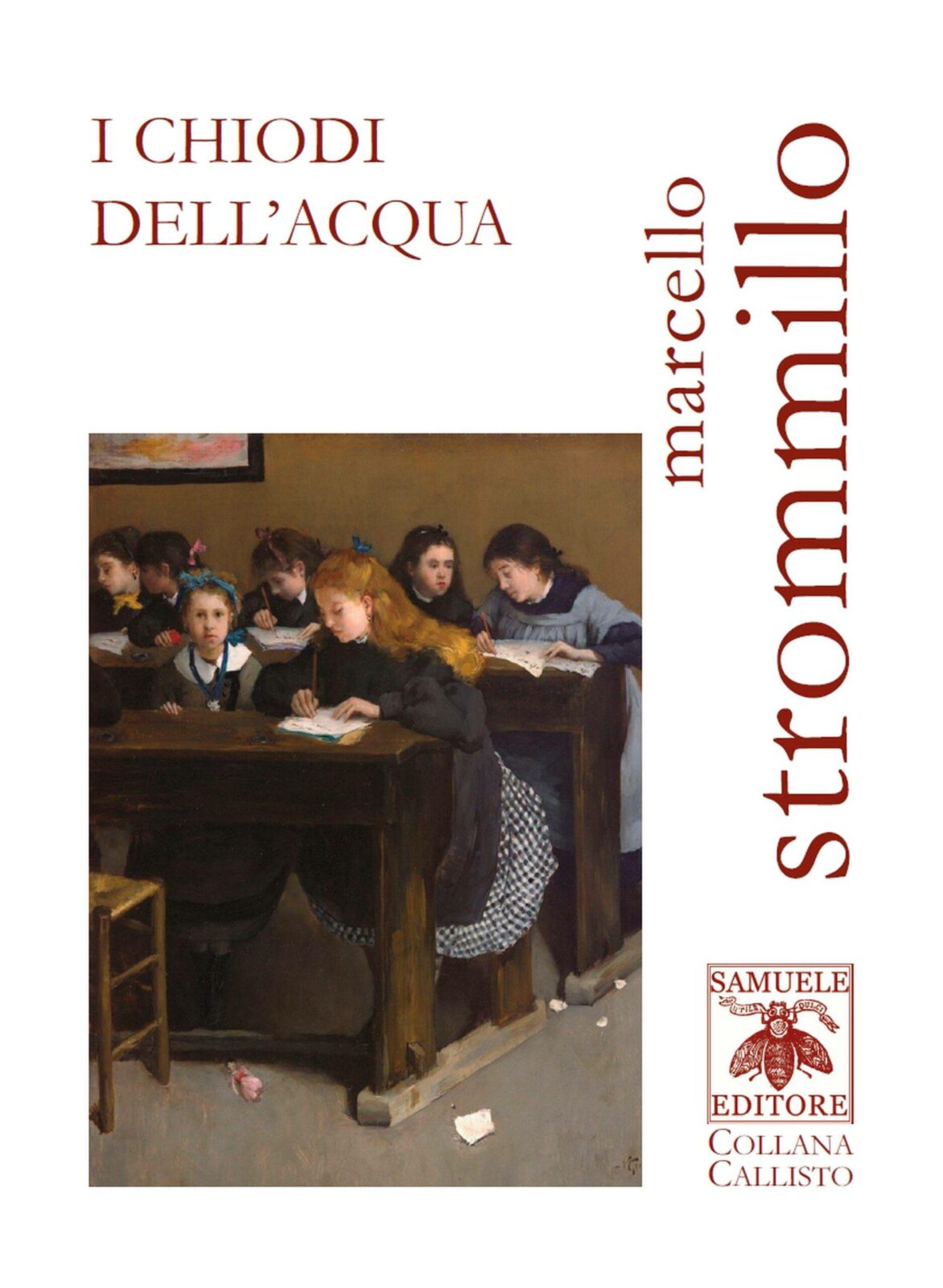
da L’Estroverso
Non vi è il faccia a faccia con l’ineffabile: tutto può essere detto e va detto; l’altro (chi è dall’altra parte della pagina; ma anche della strada, del confine, del pianeta) non è un avversario ma una persona disposta all’ascolto. E va accolto lungo le vie di un’interlocuzione che, scartando ogni pronuncia che sorga dalle scaturigini del linguaggio, scorre irrefrenabilmente tra le persone viventi, tra i vivi e i non più, tra i nascituri e i postumi (Klee), tra i terragni e i superni (numerosi sono i richiami cristologici). Solo che questa ininterrotta pronuncia, nemica d’ineffabile, si rivolge all’altro con un’affabilità disperata perché piegata sotto il peso delle figure che germinano ininterrotte e rapide si accumulano: qualcosa che somiglia a una nevrosi d’ansia del bene, a un overload d’intenzioni, a una cecità da abbagliamento, si interpone tra i dialoganti. Ed è forse il destino di buona parte della poesia che non sceglie le scorciatoie del bozzettismo, dello sfogo sentimentale, dell’indottrinamento sentenzioso e del canto fine a sé stesso. Il libro, nel suo insieme coeso, è articolato in sette parti o capitoli, ciascuno a suo modo tematico. Flauto d’aule è un resoconto scolastico (Strommillo insegna filosofia) che si risolve in una sacralizzazione dell’adolescenza, intesa come fase dell’esistenza umana di massima incandescenza, esaltazione, pericolo: il rito relazionale docente-discente, che a lampi si colora delle tinte sanguigne del sacrificio, trova qui un duplice altare nel banco e nella cattedra. La seconda parte, Parola mattutina, presenta parole che si animano, interloquendo con colui che le usa. Questo capitolo normalizza lo straniamento sistematizzandolo, un po’ alla maniera del Paz surrealista. Lo prendiamo alla stregua di un manualetto di micropoetica. Segue la terza parte eponima, che si svolge tra irritazione percettiva e smania del riposo. L’andirivieni febbrile tra i luoghi di una città si fa correlativo dell’incontro tra i vivi e i morti: lungo gl’impraticabili tragitti, fatiche e figure si coagulano, e tutto si fa simbolo. Un passo dalla prefazione di Eugenio Lucrezi per introdurre la nostra intervista.
Qual è la scintilla che ha portato il tuo “I chiodi dell’acqua”, Samuele Editore, meglio: in che modo la (tua) vita diventa linguaggio?
La scintilla de “I chiodi dell’acqua” è antica, risale ai tempi in cui, studente, frequentavo il Liceo. Erano gli anni Settanta, gli anni di piombo. Nelle scuole ed università si oscillava tra la cultura dell’analisi e un violento scontro ideologico. Tra i miei docenti allora prevaleva un mutismo scettico, una rabbia, un sottile nichilismo. Io sentivo un peso, un “chiodo” nel cuore. Avevo una sete straziante di bellezza e di senso che non trovava “forma”, non trovava linguaggio. Poi… in questa strana sospensione, un giorno entra in classe la nuova professoressa d’italiano. Senza spiegazioni pregresse, ex-abrupto, dice: “Ascoltate ragazzi, sentite che bello…”. Cosa fa? Apre un libro e comincia a leggere meravigliosamente una poesia. In seguito avrei scoperto si trattasse della poesia di Montale “A Dora Markus”. Fui investito dalla musica e dal ritmo di quei versi. Le parole nella voce della mia insegnante diventavano carne. Splendevano. Fui travolto, non capii tutto, ma fui “compreso” (cum-prendo) da quell’onda sonora. Dopo cinquanta anni lo sono ancora. Anche quando mi sono ammalato seriamente agli occhi, con il rischio di perdere la vista, le pupille sonore dei versi mi hanno sostenuto nella cicatrice della carne che cerca sempre la gioia. Soffriamo tanto perché siamo fatti per la gioia. I chiodi nel tempo diventano più spessi, più pesanti, ma attraverso essi passa un’acqua misteriosa che irrora il cuore della vita. La prima sezione de “I chiodi dell’acqua” non a caso è intitolata “Flauto d’aule”. Nasce nelle aule scolastiche. Come docente di filosofia prima al Liceo e poi in Università ho sempre insistito (è quasi un’ossessione) che i docenti non possano e non debbano usare le parole del “didattichese”, del linguaggio burocratico- bancario. Con gli studenti termini in voga come “debito”, “credito scolastico o formativo”, “saldare il debito” sono una mostruosità linguistica che tradisce la vocazione scientifica, artistica e poetica del nostro lavoro. I nostri studenti non sono i nostri “clienti”. La prima grande resistenza civile si attua con le parole. Le parole diceva Santa Caterina preparano l’anima alla tenerezza verso le cose. Noi docenti abbiamo una responsabilità poetica sulle parole che usiamo. Nelle aule è la libertà di un rapporto tra uomini che può accadere. La poesia se è precisa impone uno stile, un accento, un ritmo matematico. Come dice Antonella Anedda “La poesia che m’interessa leggere vive di realtà ma mette in discussione le apparenze, intensifica la vita”. Riporto qui una prima poesia dedicata a uno dei miei maestri, don Lorenzo Milani. L’attenzione alla lingua che ebbe don Milani è la contestazione a ogni sistema di potere, di clonazione statala. È amore alla singolarità, all’ unicità di ogni essere.
Per prima cosa comprasti una tomba,
accordasti il colore del moscerino
con l’occhio del campanile bambino.
Così spezzasti il pane della clonazione
statale con quella sottigliezza che
amò da pazzi i tuoi ragazzi.
Ora piove sulla tua tomba
sotto la costernazione della luna
mentre tu passi attraverso la cruna.
La poesia è un destino?
La poesia è un destino nel senso che è “destinata” a sorprendere un incontro. La poesia è incontro. Il primo grande incontro è il dono della nascita. Occorre riscoprire continuamente il “senso della nascita”. Solo così si potrà non censurare la morte.
un’intervista a cura di Grazia Calanna
Continua su L’Estroverso