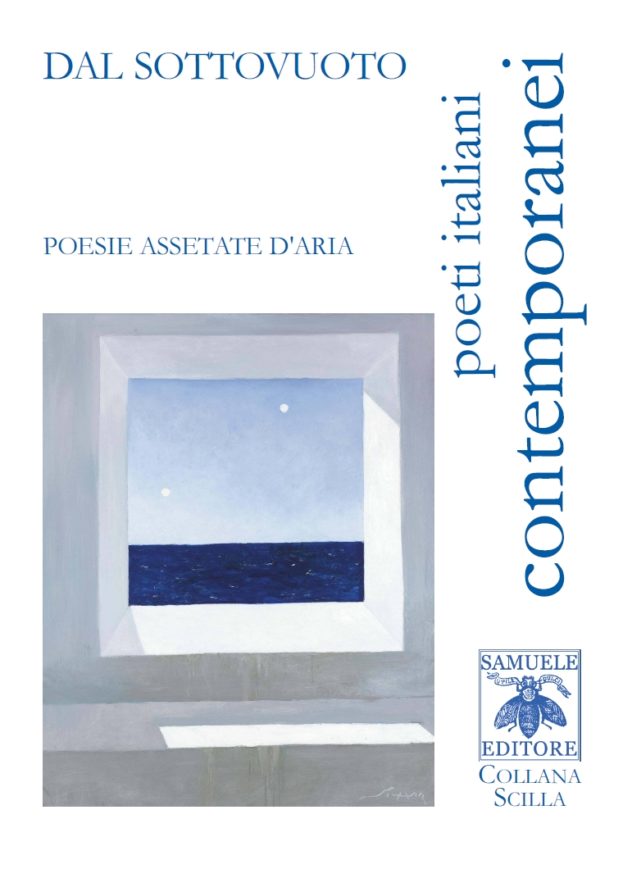dal Blog di Poesia di Luigia Sorrentino
La poesia non si accontenta di una lettura e tanto meno di una lettura distratta. Di più, ci riporta a un brusio buono, biologico, alle parole sostanziali dei sentimenti. A confermarlo ancora una volta è il percorso in versi di Gian Mario Villalta, specie nelle sue ultime pubblicazioni. Una su tutte – anomala e folgorante – Il scappamorte (Amos, collana A27, 2019), nella quale il poeta non rinuncia a far proprio il bene altrui, a renderlo condivisibile attraverso il processo estetico: «Confessi a te stesso che della felicità / sai la voglia: fa feste / all’aria intorno a te e ignora / il boccone offerto, come il cane addestrato / alla guardia del cuore / quando sfugge al guinzaglio».
Nel corso di una mirabile divagazione, Barthes affermò che «la letteratura non permette di camminare, ma permette di respirare», in quanto esperienza panica e totalizzante, che permea l’individuo e non lo accompagna soltanto durante una trasformazione interiore. Villalta, dal canto suo, esorta il lettore a un’ecologia del pensiero e di conseguenza della parola, che rifletta onestamente una doverosa ecologia sociale, sostenuta dal disarmo linguistico, e che smussi l’uso di una verbosità sempre più aggressiva e opprimente, volta a intimidire e a conquistare il fruitore dei consueti flussi di comunicazione. D’altronde, sin dalla radice οἶκος, l’ecologia si fonda su un’analisi oggettiva delle interazioni tra le singolarità e il contesto di appartenenza, ossia un’analisi che si focalizza sulle relazioni interne a una qualsivoglia realtà organica.
M. B. «Da sottomessi agli dèi a dei sottomessi / il passo è breve quanto la distanza / tra l’escandescenza e la danza». I suoi versi contenuti nell’antologia “Dal sottovuoto. Poesie assetate d’aria” (Samuele, 2020) fissano la nostra imperdonabile mancanza di consapevolezza e, di conseguenza, la nostra incapacità di prenderci cura del mondo che ci ospita. La pandemia lo ha solo messo a nudo?
G. M. V. Il riferimento non esplicito di questi versi è al saggio Homo deus, di Yuval Harari, dove troviamo una tesi portante così riassumibile: all’alba dell’umanità abbiamo inventato gli dèi per colmare l’abisso tra l’esperienza caotica del mondo e il suo possibile ordine fino a raggiungere ora, a forza di balzi in avanti di carattere cognitivo, la posizione di specie dominante e di ordinatori della terra, ovvero diventare quegli dèi che da umanità primitiva avevamo sognato. Non si creda che Yuval veda un traguardo trionfalistico, anzi, vuole mettere in evidenza la necessità di abbandonare vecchie questioni e di affrontare le nuove sfide che questa condizione comporta.
Matteo Bianchi
Continua nel Blog di Poesia di Luigia Sorrentino