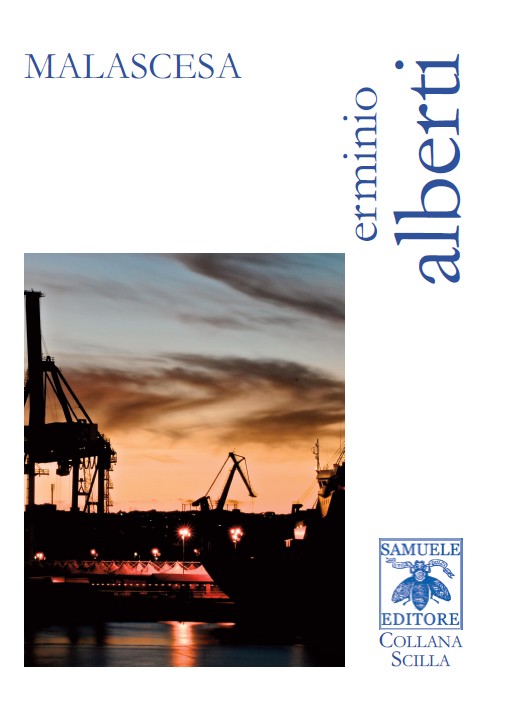Dopo esattamente diciotto mesi rileggo la prima poesia della raccolta Malascesa, senza titolo come certe poesie della silloge. Il primo verso, tuttavia indicherà l’appartenenza: “Vedi navi da crociera, come”.
La poesia ha una cesura evidente. Ma non di quelle che recidono il cordone ombelicale e separano indissolubilmente due lembi di carne.
“Vedi navi da crociera, come
luminose babilonie
e barchette solitarie,
lampare.”
A questo punto ecco la cesura. Il poeta non utilizza la prima persona del verbo “essere”. Avrebbe certamente potuto, certi frangenti indicano che avrebbe certamente dovuto. Perché salvo voli pindarici, credere che questa seconda persona non sia un soliloquio allo specchio tra l’uomo che è pronto a fuggire ed il poeta stesso che scrive mentre “vede”, dovremo credere che il poeta stesso parla di sé.
E’ traviante questa scelta verbale. E’ una scelta poetica, non una licenza, ma “scelta” che taglia in un sol colpo l’appartenenza con una passata, presente –e c’è da crederci- futura poesia, se voglio fingermi aruspice del nonsense poetico-patetico contemporaneo.
Senza divagare torniamo al punto, è essenziale.
Questa scena, un po’ “preraffaelita” –sebbene Alberti sia uomo- mi consegna un’immagine dello scrittore con un collettone vittoriano e crinoline. Tante crinoline come quelle dame “lacrimanti l’abbandono” che salutano le già stanche diligenze in partenza verso borghesissime mete.
E di colpo una ferita, tra quei versi sentiti e risentiti, tristi e finemente ricomposti proprio davanti ad un imperturbabile cielo:
“Camminiamo una sera sul fianco di un colle,
in silenzio…”
Importa sapere se alla fermata Metro della stazione di Catania fosse sera? E’ una suggestione ricrearla in mente, quella scena dico, in un qualche crepuscolo di gennaio..
“Camminiamo una sera…”
Un’evocazione verso quei “mari del sud” che adesso mi è difficile togliere dalla mente.
Anche se in due, sempre in quei “mari del sud”, sempre di soliloqui si parla.
Al crepuscolo guardare, senza fissa meta, e vedere una crociera, come una babilonia.
Babilonia perché. Punto. Aprire diatribe su come, cosa e perché sarebbe ingiusto. Andiamo avanti nel nostro discorso.
“ e barchette solitarie,
lampare.”
Qui l’evocazione è tutta mia e torna a quelle” reti tristi” tratte dal copione di una sceneggiatura cinematografica di qualche anno fa.
-”Come sono le reti?”
-“Tristi.”
La Sicilia, i Malavoglia, la pesca “perchenullasipuofareincertefamigliepercampareoltrelapesca”, basta ed avanza per smettere di descrivere questo, diciamolo pure, spettacolo un po’ avvizzito ed improvviso.
Se ti insegnano una cosa nei corsi universitari di grammatica, e ti insegnano solo questa cosa, è di mai iniziare un periodo, dopo il punto, con la parola “ma”.
“Ma è più il migrare degli aerei
a dirti che vuoi partire.”
L’avevamo detto che questa cesura tagliava qualcosa, ma questa qualcosa non la tagliava del tutto!
La “cameretta” dove il primo verso nasce e finisce è interlocutore per nascere nell’alcova della seconda finale cameretta.
Babilonia (?), le barchette lampare, l’aereo.
Forse ce ne ricorderemo avanti dei questa “gradasseria” enumerativa, tuttavia premono forti, ancora ed ancora certi “mari del sud”:
“…dalla vetta si scorge
nelle notti serene il riflesso del faro
lontano, di Torino. “Tu che abiti a Torino… ”
mi ha detto “…ma hai ragione. La vita va vissuta
lontano dal paese: si profitta e si gode
e poi, quando si torna, come me a quarant’anni,
si trova tutto nuovo.”
Quanta carne al fuoco.
“dalla vetta si scorge nelle notti serene il riflesso del faro lontano, di Torino.”
Eh sì, la mia era una romantica evocazione. In quel crepuscolo si scorge qualcosa. In entrambe le poesie si scorge un senso di movimento, che sia di andata, ritorno, rimpianto –non è forse un movimento dell’animo-speranze, vuoti, cose vane…
Questi aerei che divengono “piumati” e migrano. Che cantano (?) e dicono “che vuoi partire”.
Come le “sirene”? Sirene che cantano e dicono che “le langhe non si perdono”, se anche hai provato a non vivere il paese, vivere “lontano dal paese”.
Troppe domande, ed urge assolutamente che non si risponda.
Ma cosa cantano questi aerei, e lo chiedo “a te” che hai lasciato il “paese” e che ora sei a Torino. Ti chiedo se la meta sia almeno un po’ felice – mi si conceda una Torino senza spazio e solo immaginazione di una meta che risponda al verso seguente:
“andare dove andare”
Ma come andare dove andare? Ero certo che anche tu avevi giocato “nelle tue langhe” ai pirati malesi, e lo ricordi solo ora che hai imparato a ripeterti che “la città mi ha insegnato infinite paure: una folla, una strada mi ha fatto tremare.”
Ma forse allora quell’aereo per diversi motivi non era anch’esso una babilonia? Una babele?
Si sono intersecate irrimediabilmente le due poesie. “I mari del sud” di Cesare Pavese e “Vedi navi da crociera, come” di Erminio Alberti. Hanno perso la loro singolare unicità divenendo indistinte come rigagnoli di acqua nei solchi di terra molle di un aranceto, raccordandosi in un unico più complesso fiotto.
E chiedo, a me-ad Alberti?- se poi quel faro di quell’altra Torino – non quella savoia “perdìo”- sia una fortuna scorgerlo sospirandone la luce, e sentirsi per questo fortunati per aver visto questo spettacolo come fosse una delle “isole più belle della terra”.
Si è fatto tardi tra queste finzioni. Mi tolgo i baffi e la barba posticcia. Ho finto per un attimo di poter scorgere non certo una risposta, ma quell’inquietante domanda che dice se l’andare vale la pena. Se poi quello spettacolo fosse veramente una meraviglia senza fine, se ora dopo il crepuscolo le albe sono più lievi, se i primi raggi del sole scaldano il cuore come un “cartone Disney”.
Chiudo con queste domande e leggo, delle poesie, le due conclusioni:
“Ma quando gli dico
ch’egli è tra i fortunati che han visto l’aurora
sulle isole più belle della terra,
al ricordo sorride e risponde che il sole
si levava che il giorno era vecchio per loro.”
(Cesare Pavese)
“…andare dove andare
poiché fissi il mare,
e non ci vedi nulla.
(Erminio Alberti)
Marco Strano