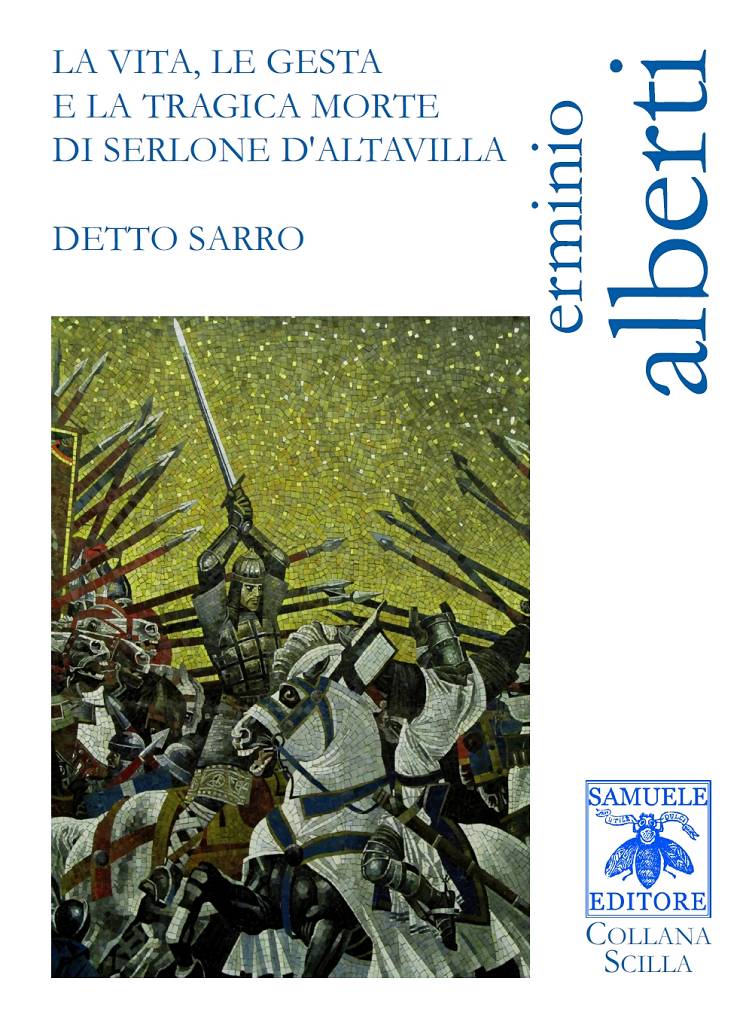
Nelle due conversazioni pubbliche con l’autore, circa la nuova opera edita da Samuele Editore, ovvero Le gesta, la vita e la tragica morte di Serlone d’Altavilla detto Sarro, riconosco d’aver commesso un errore. O almeno mezzo. Ho attribuito al testo un prevalente significato sociale, ho annotato alla silloge una spiccata vocazione alla critica dei costumi moderni in riferimento ad un passato cosciente della propria grandezza, espressa nella propria sapienza filosofica, nell’architettura geometricamente votata al divino, al senso naturale delle “cose”, all’uomo in quanto Uomo. È, tutto questo, una verità a metà, o meglio una sola della facciata di una medaglia che nasconde più retri e versi.
Si vada con ordine. C’eravamo lasciati con Malascesa, il verdissimo e verissimo Malascesa, il primitivo e disarticolatamente mirabile, come il primo abbozzo del Pinocchio di Geppetto in bottega, Malascesa che nel suo essere opera prima ha presentato un fare poesia prosaicamente lirico, lì dove la lirica è il canto del capro che sublima il pensiero in verso. Ma era un capro, seppur bellissimo. Echi “dell’andare”, del seme della vita negli avi. Andare via con un aereo, in apertura di silloge, poiché non c’è nulla oltre il concimare la terra. Avvisaglie, come teste d’ariete, di una malata sicilianità che non sa di zagara ma di melanconia nutrita dall’abbandono dell’età dell’oro, dalla giovinezza prima che rende il minore dei ricordi un paradiso in terra. Ma la silloge chiude bruscamente, senza la quadratura del cerchio, senza chiudere il cerchio.
Nel 2017, quattro anni dopo, esce Serlone. L’epico Serlone, lo storico Serlone, il tributo ad un eroe dimenticato. Intimamente paventai un accorato e passionale encomio ad un soldato del quale resta il nome in qualche cartiglio ammuffito. Non era così, ma me ne accorsi tempo dopo quando il libro era già edito. Se colloquiare con un autore del proprio libro può sembrare una pratica criticamente didascalica è bene però annotare fin da subito che va sciolto il nodo della scelta del tema epico. Alberti conosce il senso del verso che da mera parola diventa Parola, testo sacro poiché detentore di una verità assoluta. Ecco, l’epos dà al testo una connotazione sacra, riconoscendo alla parola un significato positivo, una risposta al laicissimo “Non chiederci la parola” divenuto a sua volta manifesto religioso di un fare poesia passivo e vuoto di moti d’azione intellettuale. Serlone, questo condottiero franconormanno, è pretesto per patteggiare per l’uno e non per l’altro. Normanni, europei, contro moreschi. Uno scontro molto oltre gli eserciti. Ma la pugna è breve, come lo squarcio nel cielo di Cerami, e lo scontro è scontro di fedeltà a se stessi, fedeltà alla natura atavica della propria carne. Come le rune per i normanni oramai votati ad un dio diverso dagli asi.
Serlone che muove la pugna è l’autore che muove la penna. E se Serlone dà senso a quel sangue, suo e non suo, in battaglia il poeta dà senso alla parola che si misura sui canoni delle virtù oramai sbiancate di fronte al “pensiero debole”. Debolissimo. E questo “pensiero debole” miseramente si riflette nel Nulla, vuoto di significato, dell’era del Kali Yuga. Il vuoto di senso, come uno specchio vuoto, riflette se stesso. Il nulla riflette il nulla, costantemente. L’andare “oltre” questo nulla è una possibilità non colta e non praticabile nemmeno nel ritorno alla terra madre, a quella Sicilia che è visi, ricordi, frammenti di spiagge desolatamente pacifiche ma anche segno del punto di partenza.
La Sicilia, nel Kali Yuga, non è meta. Ci sarebbe da piangere per ciò che è e più non è. E come s’aprì Malascesa si chiude Serlone d’Altavilla detto “Sarro”: partire, andare, va pure bene. Ma più dell’andare sembrerebbe che la tragedia sia il non voler ritornare. Neanche a carezzare le rovine dei castelli, delle barche alla marina di Trezza, i visi antichi degli avi. Tutto bello, insomma. Ma oggi frustratamente inutile.
Marco Strano

