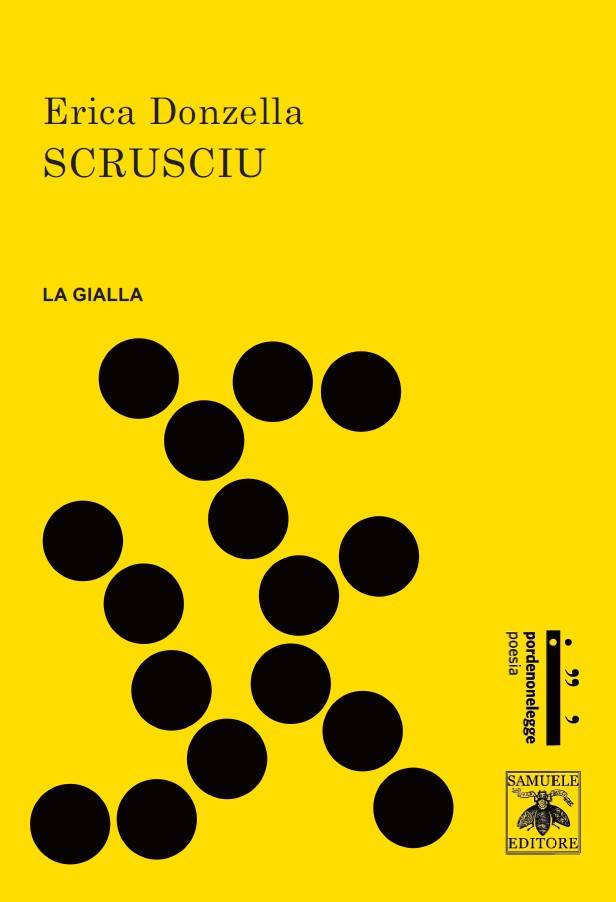Pietro Russo: Intorno alla primavera del 2015 ho scritto la mia prima poesia in dialetto. A quell’altezza il mio libro di poesie in lingua, A questa vertigine, che sarebbe uscito circa un anno dopo, era già pronto per la pubblicazione. Allo stesso tempo sentivo però esaurita quella possibilità espressiva, e non mi riferisco tanto al fisiologico estinguersi della vena creativa nel momento in cui un lavoro giunge al termine, quanto alla coscienza che l’Italiano (inteso qui, sia chiaro, come lingua di poesia) era diventato, per me, una lingua dissanguata e disincarnata; una lingua ancora comunicativa, certo, ma non in grado di comunicare l’evento della poesia. Da qui la mia plaquette in dialetto, Eppuru i stiddi fanu scrusciu, che ha visto la luce nel 2022 per i tipi de “Le Farfalle”, progetto editoriale del compianto amico e maestro Angelo Scandurra.
Leggendo il tuo “coetaneo” Scrusciu (Samuele Editore – PordenoneLegge 2022), cara Erica, oltre alla spia lessicale in entrambi i titoli che parrebbe accomunare i nostri rispettivi libri in un destino di «rumore/baccano» del mondo, mi è sembrato di scorgere lo stesso percorso – dalla lingua al dialetto – declinato proprio nei termini di «una vena di sangue sepolta» (Scrusciu, p. 36) che, dopo la prima sezione in italiano, decide di risorgere come un’esplosione prepotente nella seconda parte. Evidentemente anche per te il ritorno al sangue e alla carne ha il suono della lingua siciliana; ma quello che ti (e mi) chiedo è: quali sono le ragioni di questa urgenza dialettale, oggi?
Erica Donzella: Quando ho letto il tuo titolo – Eppuru i stiddi fanu scrusciu – ho pensato che non fosse un caso che entrambi avessimo avuto la necessità di denominare un’intestazione con la lingua che ci portiamo dentro, quella vera dei sentimenti. Ciò che poi mi ha stupita è stato leggere la tua raccolta e sentire che ogni cosa intorno – la città, il vento, il cielo e le stelle – tornassero a una dimensione ancestrale più forte, più legata alla forza della parola. Quello che ho sentito nella tua poesia è un frastuono di elementi che si rompono e che nella loro fragilità continuano a fare rumore, baccano. È anche vero che il mio scrusciu dialettale è diverso dal tuo: io l’ho confinato in una sezione (Chiafura), mentre il tuo permea un’intera raccolta. Credo che il rumore di cui io e te scriviamo sia legato a doppia mandata dal desiderio bestiale di dire le cose come stanno e di affermarle con un tono di voce profondo, che vive sotterrato sotto i cumuli di una lingua che muta di continuo e rispecchia al tempo stesso una fragilità. Insomma Pietro, ci sono cose che si possono dire e scrivere soltanto in alcuni modi e con certe intenzioni. I tuoi due versi a pagina 34 per esempio: senti chi buddellu / ri ossa ri ugna ri muzzicuna (senti che bordello/ di ossa di unghie di morsi), rende perfettamente anche in italiano ma manca il significato profondo della carnalità e perde il suo suono. L’italiano non può significare ogni cosa, non trovi? Ma c’è un altro elemento che mi incuriosisce: secondo te perché abbiamo avuto bisogno di uscire dalla dimensione del silenzio?
Pietro Russo: Prima di rispondere a quest’ultima domanda, vorrei soffermarmi sulla prima questione che, onestamente, mi mette in crisi. Cioè, sono d’accordo sull’unicità, anzi sul carattere evenemenziale del modo e dell’intenzione in cui qualcosa viene detta, ma al tempo stesso, per un mio retaggio razionalista, faccio fatica ad affermare che ci sono zone dell’esperienza umana che sono precluse alla significazione dell’Italiano. I limiti, semmai, dovrebbero essere quelli insiti nel linguaggio verbale, poco importa che sia una lingua istituzionalizzata o un dialetto o uno slang o altro: “Trasumanar significar per verba / non si porìa”. Tu citi, come esempio di “eccezionalità” del dialetto, quei miei versi; io potrei fare altrettanto (e non già per ricambiare la cortesia, bensì per ribadire il concetto) con il tuo verso «E m’arrincigghiu comu nu scursuni» (“E mi ritiro come un serpente”: p. 63) che mette bene in luce lo scarto semantico tra dialetto e lingua. Io, da siciliano, posso “vedere” il serpente/scursuni arrincigghiarisi, ma un lettore marchigiano, o ligure, può fare altrettanto? E ti sembra razionale (o democratico?) che una persona di Ancona o di La Spezia debba quindi limitarsi alla forma – per noi siculi senz’altro più debole e opaca – del “ritirarsi” della serpe? A questo punto, io credo, la tua domanda sul silenzio acquista un senso ulteriore. Provo a scorgere una possibile via d’uscita a questo dilemma in alcuni tuoi versi ‘italiani’ di Scrusciu: «Dov’è mancato il corpo / è stata la mente / a comandare la vita» (p. 12). Penso seriamente, infatti, che la nostra lingua nazionale, usurata dalla comunicazione quotidiana e quindi dai mezzi che rendono possibile questi scambi verbali, si sia sempre di più allontanata dalle ragioni del corpo, della terra, della nuda materia-madre, per abbracciare alcune istanze che – come scrivi molto bene – vorrebbero comandare la vita, cioè fissarla e costringerla verso una direzione che per natura non le appartiene. È questo snaturamento della vita che conduce all’afasia, e di conseguenza alla nostra urgenza di cercare, nella lingua della poesia, una fonte perenne di “scrusciu” che non sia solo un “rumore” di sottofondo, ma un baccano-concerto, un coro, una polifonia – anche stonata e dissonante – di voci umane. E in fondo non sembra anche a te che la nostra comune scelta del dialetto sia una strada per rimarcare l’alterità della lingua della poesia?
Continua pordenoneleggepoesia.it