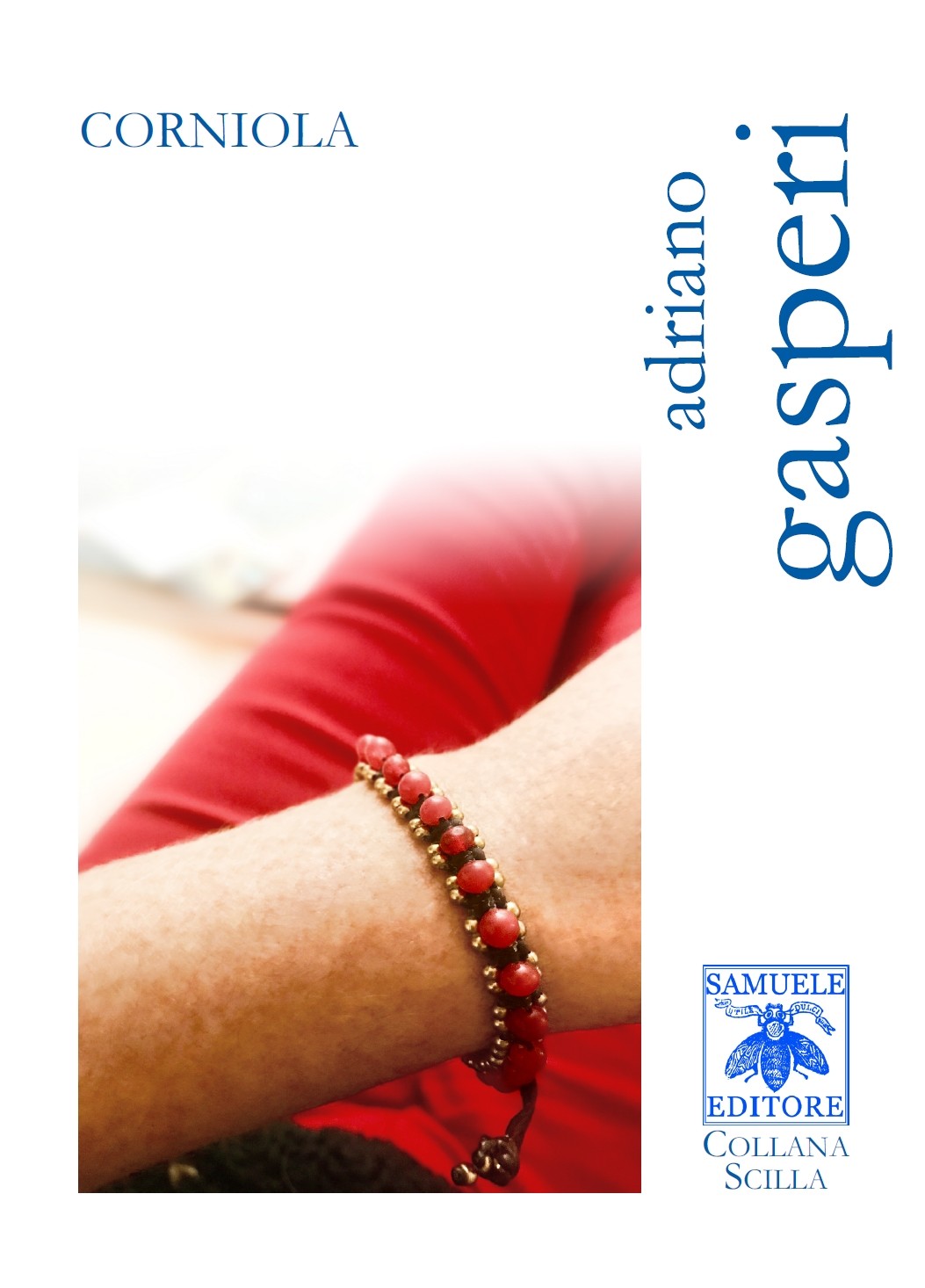da L’Adigetto
Notti, giorni, mesi e anche anni per aiutare chi rischia di morire per malattie banali, curabili con semplici medicinali. Uomini, donne e bambini che lottano quotidianamente per sopravvivere alla fame, alla guerra, alle catastrofi naturali, alle epidemie e alle malattie.
Ma per fortuna non tutti hanno gli occhi bendati e fanno, invece, del loro lavoro una missione di vita per salvare e porgere una mano a quanti vivono in terre lontane, dove si combatte ogni giorno per restare in vita. Dove si muore anche per un morbillo.
Sono gli «angeli con i camici bianchi», chirurghi, odontoiatri, pediatri, infettivologi, anestesisti e quanti mettono la loro professionalità a servizio di chi è meno fortunato.
Dottori e volontari di ogni età che hanno fatto le valigie, abbandonato realtà completamente diverse e più sicure, per raggiungere i paesi del terzo mondo,  dove non solo il covid ma l’aids, l’ebola, epidemie e tante altre malattie fanno vittime ogni giorno e orfani numerosi bambini.
dove non solo il covid ma l’aids, l’ebola, epidemie e tante altre malattie fanno vittime ogni giorno e orfani numerosi bambini.
Tra gli «angeli bianchi del terzo mondo» c’è anche il dott. Adriano Gasperi nato a La Spezia si è laureato in Medicina a Pavia, conseguendo poi due specializzazioni in Anestesia e Rianimazione e Tecnologie biomediche.
Nei suoi oltre dieci anni di professione tra Italia e Africa, ha lavorato in Uganda e Mozambico. Dal 1986, si è poi dedicato al coordinamento di due programmi di cooperazione sociosanitaria finanziati dal governo italiano, rispettivamente in Somalia ed Egitto. Ha partecipato a molte missioni internazionali, portando con sé non solamente la sua professionalità, ma anche la sua umanità e una profonda dedizione.
A termine del suo girovagare per il mondo il dott. Gasperi ha scelto di trascorrere il pensionamento in Gran Canaria, in forma di libertà per così dire «africana» in un ambiente molto favorevole dal punto di vista climatico e fonte di ispirazione di centinaia di versi scritti con l’inchiostro dell’emozione e frutto della raccolta di poesie «Corniola», pubblicata da Samuele Editore.
Ma il dottore non vuole fermarsi perché il suo moto è «camminare per vivere a lungo» verso nuove emozioni che sono all’orizzonte e che lui stesso definisce Sindrome di Ulisse.
In questa intervista il dott. Gasperi ha voluto raccontarci alcune sue esperienze di vita e le motivazioni che lo hanno portato a lasciare l’Italia per dedicarsi in primis agli altri, agli ultimi e con quale mission.
Chi è il dott. Adriano Gasperi  Nato a La Spezia nel 46, scorpione d.o.c., studi classici in vista di entrare in Marina e girare il mondo. Sogno spento in fondo ad un burrone appena compiuto i diciott’anni. Mesi di assidua frequentazione di ospedali e sale operatorie lo spingono ad iscriversi a Medicina a Pavia e, a partire dal quarto anno, a vivere, in uno dei primi reparti di rianimazione del Paese, la realtà della morte e il miracolo della vita. Nato a La Spezia nel 46, scorpione d.o.c., studi classici in vista di entrare in Marina e girare il mondo. Sogno spento in fondo ad un burrone appena compiuto i diciott’anni. Mesi di assidua frequentazione di ospedali e sale operatorie lo spingono ad iscriversi a Medicina a Pavia e, a partire dal quarto anno, a vivere, in uno dei primi reparti di rianimazione del Paese, la realtà della morte e il miracolo della vita.Si laurea nel 1972 con una tesi frutto di un lavoro di ricerca condotto a Mosca, sotto la direzione del Prof. V.Niegowsy, uno dei padri della rianimazione mondiale. Inizia a lavorare a Pavia, con il Prof. Diego Carbonera, si specializza in Anestesia e rianimazione nel 1974. Poco dopo parte per la prima missione africana in Kampala, Uganda, dove fonda il reparto di terapia intensiva. Rientrato in Italia si specializza in Tecnologie Biomediche nell’81 per poi ripartire verso l’Africa. Questa volta in Mozambico, a Maputo, dove tiene corsi e dirige i blocchi operatori per quattro anni. Dal 1991 lavora in Olanda, Corea del Sud e Tunisia. Rientrato definitivamente in Italia nel 2005, si riavvicina alla pratica medica con particolare interesse all’utilizzo clinico di campi elettromagnetici a bassa intensità e frequenza; continua al contempo una attività di consulenza in relazioni scientifiche internazionali che lo porta tra l’altro a ricoprire il ruolo di Segretario generale del comitato Scientifico di Expo Milano 2015, dall’inizio della candidatura fino al 2012, quando il comitato viene sciolto dalla direzione dell’evento. |
Dott. Gasperi cosa l’ha spinta a raggiungere luoghi così diversi dai nostri?
«Una sindrome abbastanza rara, la ricerca continua del nuovo e del non conosciuto. La chiamo Sindrome di Ulisse. Fin da piccolo ho sempre sognato molto e cercato di raggiungere mete raggiungibili, ma quando la meta era a portata di mano già un nuovo obiettivo si materializzava e dunque mi lanciavo nel nuovo progetto.
«È stato questo il filo di una vita fatta di molte scelte, senza pensare a strategie di carriera.»
Perché ha deciso di mettere a disposizione dei più bisognosi il suo talento professionale?
«La prima volta fu il caso. L’Università di Pavia ricercava un anestesista esperto da inviare in Uganda nel quadro di una nascente cooperazione interuniversitaria tra Pavia e l’Università di Makerere a Kampala.
«Il Rettore e il Preside della Facoltà, non trovando il profilo professionale richiesto si ricordarono di un giovane medico che aveva deciso di preparare la tesi di laurea a Mosca ed al quale avevano assegnato il Premio Palumbi, per la miglior tesi discussa in tutte le Facoltà nel 1971.
«E mi convocarono. La mia risposta fu quasi immediata. L’unica riserva, caduta in poche ore, fu di parlarne con la moglie, anche lei medico anestesista, avevamo appena avuto il primo figlio, non fu semplice convincere i genitori e suoceri. Ma nonostante tutti e tutto in pochi mesi, partì alla volta di Kampala.»
Com’è l’Africa vista dagli occhi di un medico?
«La mia visione è limitata dal fatto che ho vissuto in città capitali: Kampala, Maputo, Mogadiscio. Ogni paese è una Africa, frutto di storie differenti, basti pensare alle conseguenze lasciate dalle diverse colonizzazioni: l’imprinting inglese, che ancora si riscontrava in Uganda, nulla aveva a che fare con la saudade portoghese del Mozambico, e men che meno con il lascito italiano in Somalia.
«Quando andai in Uganda ad esempio in pochi capivano l’utilità che sarebbe derivata al paese dal disporre di un reparto di rianimazione. Quando poi si videro i risultati e se ne comprese meglio la funzione, non solo per quanto riguarda la cura di pazienti critici, ma anche per la formazione del personale medico e non, l’apprezzamento fu generalizzato.
«Ormai sono assente da troppi anni dall’Africa, ma da quanto leggo e ascolto, le cose non sono poi così tanto cambiate: carestie, fame, fondamentalismi, corruzione, sono tra le parole attuali ora come allora, ai miei tempi.
«Almeno tre mi paiono i fatti nuovi adesso rispetto ad allora, la perdita, a partire dalla caduta del muro di Berlino, di valore strategico del continente africano per i due blocchi della Guerra fredda, la crescente emigrazione verso l’Europa, e la fortissima presenza economica cinese.»

Ci racconta della sua esperienza in Mozambico e in Somalia?
«Due esperienze molto diverse. In Mozambico le mie funzioni erano sostanzialmente cliniche e didattiche: organizzazione del lavoro delle sale operatorie e formazione del personale. Ricordo che uno dei primi problemi che mi trovai di fronte fu un modello organizzativo molto lontano da quello cui ero abituato.
«Evitando accuratamente di replicare ciò che conoscevo, ma cercando di integrarlo con la realtà che trovai, dopo qualche settimana si cominciarono a notare i primi risultati.
 La soluzione era far sì che tutte le componenti necessarie per un intervento chirurgico fossero presenti contemporaneamente in sala operatoria: paziente, materiali, farmaci, servizi, personale… detta così può sembrare una barzelletta, ma le garantisco che ja acabò o ainda no chegou (è già finito, non è ancora arrivato) furono l’incubo dei primi tempi di servizio a Maputo.
La soluzione era far sì che tutte le componenti necessarie per un intervento chirurgico fossero presenti contemporaneamente in sala operatoria: paziente, materiali, farmaci, servizi, personale… detta così può sembrare una barzelletta, ma le garantisco che ja acabò o ainda no chegou (è già finito, non è ancora arrivato) furono l’incubo dei primi tempi di servizio a Maputo.
«Riprendo testualmente da un’intervista rilasciata al termine della mia missione a Maputo e pubblicata nel 1985 sul settimanale Il Medico di Italia in un articolo dal titolo Un anestesista in Africa dall’Uganda al Mozzambico che scriveva: – “Ja acabou è stata la frase che per mesi mi ha perseguitato, spiegandomi qualsiasi deficienza che via via incontravo. Ho cercato quindi di tentare un minimo di programmazione, di prevedere i fabbisogni, le necessità che abbiamo analizzato le cause responsabili di cancellazioni di interventi programmati e siamo riusciti a ridurle drasticamente, semplicemente migliorando la comunicazione tra le persone coinvolte nell’ assistenza ai pazienti”.
«In Somalia si trattava invece di coordinare i numerosi progetti di cooperazione in ambito sanitario e sociale finanziati dal governo italiano. Avevo un ufficio presso l’Unità di Cooperazione, nel compound dell’Ambasciata, e mi fu possibile girare abbastanza per il paese, fino a quando le condizioni di sicurezza lo permisero.»